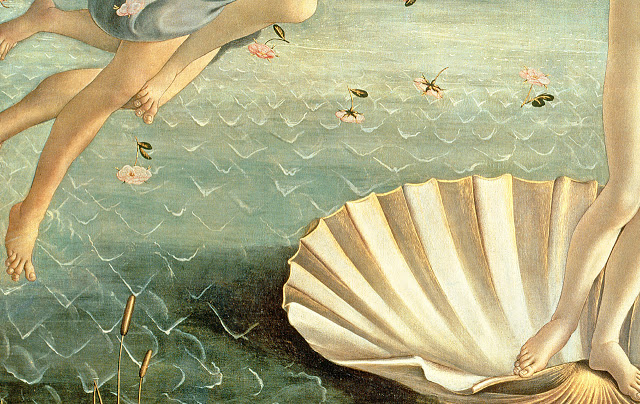Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 25 marzo 2009 n. 7207
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. PANZANI Luciano – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26870/2005 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE AMMIRAGLIO BERGAMINI 12, presso l’avvocato CAMMARERI PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGISTRELLI Marina, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente-
contro
G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14, presso l’avvocato BARBANTINI Maria Teresa, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARILE FRANCO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 337/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato PIETRO CAMMARERI, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ancona con sentenza del 12 febbraio 2004 pronunciò la separazione personale dei coniugi P.P. ed G. A.M. che addebitò al marito per avere costui intrapreso una relazione omosessuale , assegnando alla moglie a titolo di mantenimento il godimento esclusivo della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi.
In parziale accoglimento delle impugnazioni delle parti, la Corte di appello di Ancona ha revocato l’assegnazione della casa coniugale alla G., cui ha attribuito l’assegno di mantenimento di Euro 500,00 a carico del coniuge; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, osservando: a) che anche la relazione omosessuale del marito costituisce violazione dell’obbligo della fedeltà ai sensi dell’art. 143 cod. civ., e motivo di addebito a carico del coniuge che vi è incorso a meno che quest’ultimo provi che la pratica omosessuale è dovuta ad una condizione morbosa di tipo psico- patologico tale da impedirgli la prosecuzione di una normale attività sessuale con l’altro coniuge e da rendergli nel contempo ineluttabile quella concretamente seguita; b) che vi era notevole sproporzione tra le condizioni economiche dei coniugi perché la G., inabile al lavoro, possedeva una modesta pensione di circa Euro 600,00 mensili, oltre ad un nono di un modestissimo appezzamento di terreno; mentre il marito alla pensione di oltre Euro 800,00 aggiungeva la proficua attività di restauratore e di antiquario.
Per la cassazione della sentenza, quest’ultimo ha proposto ricorso per due motivi, cui resiste G.A.M. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, P.P., deducendo omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia;
censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che egli non aveva contestato la causa del fallimento del matrimonio ravvisata dal Tribunale nella sua relazione omosessuale, senza considerare che in effetti la cessazione della convivenza era dovuta al venir meno dell’affectio coniugalis in ciascuno di essi e costituiva l’epilogo della separazione di fatto che già si protraeva da tempo ed era stata peraltro tra di essi concordata. Si duole altresì che la Corte di appello abbia ritenuto provata la relazione suddetta, non ricavabile da alcuna risultanza istruttoria; e soprattutto che l’abbia ritenuta causa unica della crisi matrimoniale, omettendo di motivare su tali circostanze malgrado egli avesse con l’appello proposto contestato l’addebito suddetto.
Il motivo è inammissibile.
La più qualificata dottrina e la giurisprudenza hanno ripetutamente posto in evidenza che nel vigente sistema processuale il giudizio di appello non costituisce un iudicium novum con effetto devolutivo generale sull’intera pronuncia di primo grado, ma la cognizione del giudice di appello resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi come richiesto dall’art. 342 cod. proc. civ.; i quali perciò assolvono alla funzione di individuare l’oggetto della domanda di appello e di stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata.
Da qui la duplice regola: 1) che sono proprio i motivi formulati a determinare l’oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, ad incidere sullo stesso esercizio del potere d’impugnazione, con conseguente cristallizzazione del “thema decidendum” su cui il giudice di questo è chiamato, ed è tenuto, a pronunciare, ed impossibilità di considerare proposti all’esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell’atto di appello. 2) che, d’altra parte, il giudice d’appello deve contenere il riesame della causa nei limiti segnati dai motivi d’appello (“tantum devolutum quantum appellatum”), enunciati con esposizione idonea a consentire l’individuazione dei punti e delle questioni da riesaminare e da fissare; per cui mentre gli è concesso addurre a sostegno della sua decisione argomenti giuridici non prospettati dalle parti o diversi da quelli prospettati, mantenendo fermi i fatti dedotti dalle parti nelle rispettive censure, non gli è consentito trasformarne il contenuto e la natura né tanto meno mutarne i presupposti di fatto e le situazioni giuridiche conseguenti, né compiere nuove indagini su elementi di fatto diversi da quelli già dedotti. Sicché ove il riesame esorbita dai motivi suddetti, detto giudice incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c..
Ora, nel caso concreto il Tribunale di Ancona, come riferito dalla sentenza impugnata, aveva accertato che il P.P. nell’ultimo periodo della convivenza matrimoniale aveva intrapreso una relazione omossessuale con tale P.G., commesso del proprio negozio di antiquariato, in tal modo violando l’obbligo della fedeltà; e che proprio tale relazione aveva compromesso il matrimonio nonché la possibilità di prosecuzione della convivenza, anche perché il ricorrente era andato a convivere con il P.G., lasciando la casa coniugale.
Il ricorrente nell’atto di appello non ha censurato “né la relazione omosessuale allacciata in costanza di matrimonio, nè il nesso eziologico tra questa e l’intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale (presupposti) affermati dalla sentenza” (pag. 5 sent.); ma ha lamentato che fosse stata considerata causa di addebito la sua tendenza omosessuale, asseritamente considerata, invece, dalla giurisprudenza quale causa di invalidità del vincolo (dovuta ad incapacità psichica di comprendere i doveri del matrimonio) non sanabile neppure per effetto di una lunga convivenza o dalla buona fede dell’altro coniuge. Pertanto, la sentenza impugnata ha esaminato soltanto questo profilo specificamente dedotto dall’appellante (Cass. 13014/2004; 7629/2003; 19681/2002); che ha disatteso: anche perché la questione suddetta era del tutto distinta da quelle relative alla prova del rapporto intercorrente con il P.G. nonché a quella della sua idoneità a provocare la frattura del matrimonio, ciascuna delle quali aveva costituito oggetto di specifica pronuncia da parte del Tribunale; ed anzi era stata formulata proprio sul presupposto logico dell’avvenuto accertamento di detta relazione (più non posta in discussione da alcuna delle parti), sostanzialmente proponendo alla Corte di appello il quesito di stabilire se la relazione omosessuale potesse includersi nella categoria delle violazioni del dovere della fedeltà, ovvero se dovesse piuttosto consideraci causa di annullamento del matrimonio, e perciò inidonea a costituire comportamento addebitabile ai sensi dell’art. 151 cod. civ..
Conseguentemente, il motivo di censura si rivolge inammissibilmente contro le statuizioni della sentenza del Tribunale, che in base al disposto dell’art. 360 cod. proc. civ., non possono costituire oggetto del ricorso; ed introduce doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongono a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito e prospettano, comunque, questioni fondate su elementi di valutazione diversi da quelli dedotti nella precedente fase processuale, involgendo peraltro accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito perché non richiestone.
Ove, poi, il ricorrente abbia inteso sostenere che la censura ora proposta era comunque desumibile dall’atto di appello, in quanto dedotta fin dal giudizio di primo grado, allora sussiste altro profilo di inammissibilità del motivo: posto che il P.P. avrebbe dovuto trascrivere il contenuto dell’atto suddetto nella parte in cui assumeva di aver formulato la censura e quindi far rilevare la illogicità e/o la contraddittorietà al lume di esso, dell’interpretazione della domanda prospettata dalla sentenza, o la violazione da parte dei giudici di appello delle regole di ermeneutica che erano tenuti ad osservare nell’interpretazione degli atti giudiziari. Laddove il motivo è rivolto a denunciare esclusivamente un error in iudicando del giudice di appello nel ritenere documentata la ragione di addebito dedotta dalla controparte: che non sarebbe invece supportata dalle risultanze istruttorie.
Con il secondo motivo il P.P., deducendo violazione di legge, nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia, censura la sentenza per aver ritenuto che fra le proprie condizioni economiche e quelle della moglie sussistesse una sproporzione in favore di quest’ultima, senza neppure valutare tutti gli elementi contrari a tale assunto da lui addotti nel giudizio di merito; ed in base alla mera presunzione, peraltro del tutto illegittima, che egli aveva continuato proficuamente l’esercizio del negozio di antiquariato, invece cessato. Addebita, quindi alla Corte di appello di non aver considerato i maggiori redditi della G., risultanti anche dalla somma incassata per la vendita di un terreno, e di aver posto a suo carico un esborso assolutamente insostenibile al lume del modesto ammontare della pensione percepita.
Anche questo motivo è inammissibile.
Il ricorrente sostanzialmente lamenta che la Corte di appello non abbia valutato imprecisati documenti che sarebbero stati prodotti o comunque acquisiti nel corso dell’istruttoria, fra cui menziona “le risultanze investigative compiute dalla Guardia di Finanza”, c.d. ai quali rinvia, senza considerare che il controllo della congruità e logicità della motivazione, al fine del sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto del giudice di merito, postula la specificazione da parte del ricorrente – se necessario anche mediante la trascrizione integrale nel ricorso – della risultanza (parte di un documento, di un’affermazione del consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione della controparte, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dal giudice: perché solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione – alla quale è precluso, salva la denunzia di “error in procedendo”, l’esame diretto dei fatti di causa – di delibare la decisività della risultanza non valutata. Con la conseguenza che deve ritenersi inidoneo allo scopo il ricorso con cui, nel denunziare l’omessa valutazione da parte del giudice di merito di una circostanza decisiva, ci si limiti a rinviare alla prospettazione fatta negli atti di causa.
D’altra parte, nella sentenza impugnata, vi è un’articolata motivazione del convincimento della Corte territoriale in ordine alla sproporzione esistente tra la situazione economica del P.P. e quella della moglie: atteso che quest’ultima percepiva una pensione di circa 600 _ mensili ed era titolare di 1/9 di un appezzamento di terreno esteso are 29,40 avente l’irrisorio valore di L. 250.000, nonché di un conto corrente avente nel (OMISSIS) una somma via via impiegata per sopperire ai bisogni fondamentali. Mentre il ricorrente era titolare di una pensione di Euro 872,47, ed inoltre svolgeva utilmente – come già in precedenza – l’attività di restauratore e commerciante di antiquariato con il convivente P.G., non avendo egli documentato di averla mai cessata, e dimostrando anzi numerosi indizi che il suo esercizio proseguiva proficuamente.
Non è riscontrabile, quindi, la mancanza od insufficienza di motivazione lamentata dalla ricorrente, mentre le diverse valutazioni in fatto prospettate con la doglianza non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, nel quale le valutazioni operate dal giudice del merito dei fatti e delle risultanze probatorie non sono censurabili, ove il convincimento dello stesso giudice sia – come nel caso di specie – sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della G. in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009