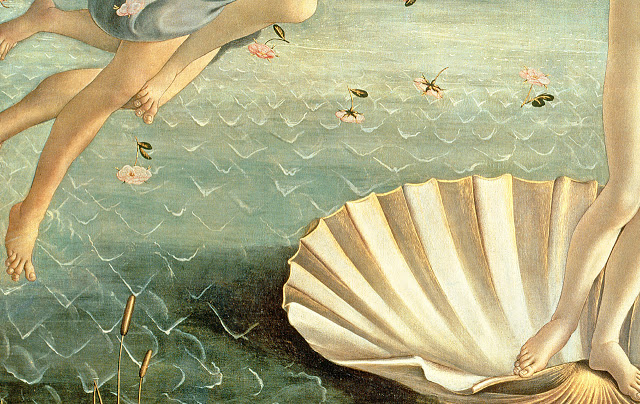Tribunale di Pavia, sentenza del 2 febbraio 2006
Con ricorso depositato in cancelleria il 15 giugno 2005 il sig. Celeste (sic) Z., per mezzo dell’avv. Guido Baroni, premesso di essere nato come M., ma che poi, con decreto del 3 novembre 2003, il prefetto di Pavia gli aveva concesso di cambiare detto prenome M. in quello di Celeste, premesso altresì di essere celibe e senza discendenti, premesso infine che, con sentenza n. 26 del 10 gennaio 2005, depositata in cancelleria il 19 gennaio 2005, di questo stesso Tribunale di Pavia, egli era stato autorizzato a «sottoporsi al trattamento chirurgico necessario per rendere il suo corpo il più simile possibile a quello di una donna» e che, effettivamente, il 4 febbraio 2005 egli si era poi sottoposto presso l’ospedale di Trieste a un’operazione chirurgica con la qual egli erano stati completamente asportati entrambi i testicoli, chiedeva a questo Tribunale di Pavia che, tenuto anche conto del suo orientamento psicosessuale femminile e del suo aspetto esteriore del pari femminile (ottenuto anche per effetto di cure ormonali già da lungo tempo intraprese), disponesse la rettificazione del suo atto di nascita, nel senso di attribuirgli il sesso femminile, nonché nel senso di cambiare il prenome da Celeste in L.I. Insieme con questo ricorso venivano depositati in cancelleria alcuni documenti, tra i quali una copia autentica della suindicata sentenza e un certificato dell’ospedale di Trieste del 5 aprile 2005, attestante l’avvenuta orchiectomia bilaterale.
Con decreto del presidente del tribunale del 24 giugno 2005 veniva disposto procedersi in camera di consiglio, veniva assegnato il processo al collegio che oggi qui decide, veniva fissata l’udienza collegiale, in camera di consiglio, per il 19 settembre 2005 e veniva infine disposto che il cancelliere comunicasse subito gli atti al pubblico ministero: il che avveniva il 28 giugno 2005.
All’udienza in camera di consiglio del 19 settembre 2005, dinanzi al collegio così nominato, comparivano l’avv. Baroni, per il ricorrente, e il sostituto procuratore della repubblica dott.ssa Luisa Rossi i quali chiedevano concordemente che il ricorso venisse accolto; il collegio si riservava di decidere.
Con ordinanza del 23 settembre 2005, depositata in cancelleria il 29 settembre 2005, questo stesso collegio, rilevato che il ricorrente si era fatto asportare entrambi i testicoli, ma non il pene, in tal modo conservando un indiscutibile attributo del sesso maschile, al quale tuttavia intendeva abdicare, fissava nuova udienza collegiale in camera di consiglio per il 20 gennaio 2006, per dar modo al procuratore del ricorrente medesimo e al pubblico ministero di «illustrare in maniera approfondita la problematica ora indicata».
All’udienza del 20 gennaio 2006, presente anche il ricorrente personalmente, il suo procuratore avv. Baroni e il sostituto procuratore della repubblica dott.ssa Luisa Rossi hanno illustrato oralmente la problematica indicata nella suddetta ordinanza; e hanno insistito entrambi per l’accoglimento del ricorso. L’avv. Baroni ha prodotto inoltre una memoria scritta, recante in allegato la copia fotostatica una relazione pubblicata di recente su una rivista scientifica specializzata e relativa alle operazioni chirurgiche possibili per trasformare, in qualche modo, un uomo in una donna.
Il collegio si è riservato di decidere; e ora, con la presente sentenza, decide.
Premesso che le concordi richieste delle parti (una delle quali è il pubblico ministero) non possono, in questa procedura che riguarda diritti indisponibili e dove le norme applicabili (sullo stato civile e sulla determinazione del sesso) hanno evidente carattere di ordine pubblico, vincolare in alcun modo la decisione del giudice, ritiene il collegio giudicante di dovere in primo luogo affrontare alcune questioni preliminari di carattere processuale e di doverle risolvere, dopo attenta e autonoma disamina, in maniera non diversa da come esse furono risolte, dapprima con la sentenza che autorizzò l’odierno ricorrente a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario per rendere il suo corpo il più possibile simile a quello di una donna, poi col decreto del presidente del tribunale che fissò l’udienza in camera di consiglio nella presente procedura, e infine con l’ordinanza di questo stesso collegio emessa a seguito di riserva dopo quella udienza.
E quindi, più precisamente, valgano le considerazioni seguenti.
L’art. 3 l. 14 aprile 1982 n. 164 è sufficientemente chiaro nel delineare un complesso procedimento in due fasi per pervenire a un’attribuzione ope iudicis a chi lo richieda, verificate tutte le condizioni di legge, di un sesso diverso da quello risultante dall’atto di nascita, ogni qual volta (sia ben chiaro) non si tratti già di correggere un errore dell’atto di nascita medesimo, bensì di riconoscere un mutamento della persona, intervenuto successivamente (nel corso della vita del soggetto); e più precisamente: una prima fase del processo, nella quale si accerta il diritto del ricorrente di ottenere l’attribuzione di un sesso diverso e lo si autorizza a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo, e una seconda fase, nella quale si accerta l’avvenuta modificazione chirurgicamente effettuata e si dispone l’attribuzione del sesso diverso risultante.
Mentre nulla viene detto circa il modus procedendi della prima fase (e nel silenzio della legge sembra doversi preferire la soluzione di seguire l’ordinaria procedura contenziosa e di decidere alla fine con una sentenza), il 2° comma del citato art. 3 della legge è invece chiaro nel senso di stabilire che la seconda fase deve svolgersi in camera di consiglio. Anche dopo l’istituzione del giudice unico in tribunale, i procedimenti in camera di consiglio sono tutti di competenza del collegio (art. 50 bis, ultima parte, c.p.c.). Il procedimento si svolge nei modi descritti nell’art. 738 c.p.c.
Le due fasi del procedimento sono tra loro del tutto autonome, al punto che, più propriamente, deve parlarsi, non tanto di due fasi di un unico processo, bensì di due processi distinti, sebbene in qualche modo tra loro collegati. Infatti la c.d. seconda fase è solo eventuale, in quanto che, non solo essa presuppone che il trattamento chirurgico autorizzato sia poi effettivamente avvenuto e abbia avuto successo (il che non è affatto scontato), ma anche che, pur avvenuto l’intervento chirurgico e con successo, il soggetto persista nella volontà di veder giuridicamente riconosciuto il mutamento del proprio sesso e proponga a tal fine un nuovo ricorso. E quindi, da un punto di vista formale, la seconda fase processuale non può essere considerata una prosecuzione della prima; d’altra parte però, non vi sono limiti di tempo per darvi inizio.
Mentre l’art. 2 della legge citata prevede espressamente come necessaria e obbligatoria la partecipazione al giudizio del pubblico ministero (al punto di doversi ritenere che, qualora non esistessero parti convenute, per essere l’attore non coniugato e privo di discendenti, come nel caso presente, il pubblico ministero dovrebbe considerarsi non un intervenuto, ma un convenuto, l’unico convenuto), viceversa nulla viene detto circa la partecipazione, o meno, del pubblico ministero alla seconda fase (in camera di consiglio). Purtuttavia logica vuole che anche in questo procedimento in camera di consiglio la partecipazione del pubblico ministero sia ugualmente necessaria, in quanto che è innegabile che, da un punto di vista sostanziale, questo procedimento è la prosecuzione di quello ordinario che lo ha preceduto (la c.d. prima fase). Aggiungasi che, sia pure con procedura più semplice (in camera di consiglio), si controverte pur sempre sul sesso, e quindi sullo «stato delle persone». Pertanto, quanto meno per analogia, sembra dover trovare applicazione il disposto dell’art. 70, n. 3, c.p.c., con conseguente necessità della partecipazione del pubblico ministero anche alla seconda fase del procedimento relativo al cambiamento di sesso.
Deve infine precisarsi che questa stessa seconda fase, pur svolgendosi in camera di consiglio, si conclude, non già con un’ordinanza, come solitamente avviene, bensì (eccezionalmente) con una sentenza: e ciò per espressa disposizione di legge. Infatti, mentre la prima parte del mentovato art. 3 è esplicita nello stabilire che l’autorizzazione a procedere al «trattamento medico-chirurgico» necessario per «realizzare un adeguamento dei caratteri sessuali» deve essere data (o negata) con sentenza, invece non altrettanto esplicito è il 2° comma, dove si legge semplicemente che «il tribunale dispone la rettificazione in camera di consiglio» (e niente altro). Ma l’art. 4 (che segue immediatamente) toglie ogni dubbio, perché esordisce con le parole: «La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso … ecc.»: non dunque la sentenza che aveva autorizzato il trattamento chirurgico, ma proprio la sentenza che attribuisce al ricorrente un sesso diverso da quello risultante dall’atto di nascita, rettificando quest’ultimo. Quindi, per espressa disposizione di legge, entrambe le fasi del complesso procedimento disciplinato dall’art. 3 della legge in esame si concludono ciascuna con una sentenza: la prima sentenza, pronunziata al termine di un procedimento che si svolge secondo le forme ordinarie (a parte l’introduzione con ricorso, invece che con atto di citazione), la seconda sentenza, pronunziata al termine di un procedimento in camera di consiglio.
Il tribunale non si nasconde tuttavia che questa configurazione processuale, da ritenersi incontrovertibile quando fu emanata la l. 14 aprile 1982 n. 164, oggi potrebbe essere messa in discussione, dopo l’entrata in vigore del regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396), il quale, innovando rispetto all’ordinamento precedente (del 1939, e anche rispetto a tutti quelli ancora precedenti, fin dall’epoca napoleonica), ha disposto che la rettificazione degli atti dello stato civile d’ora in avanti non si facciano più con sentenza, bensì con decreto, sia pure motivato (art. 96): è rimasto fermo il procedimento in camera di consiglio (ieri come oggi), ma è cambiato il provvedimento conclusivo (ieri sentenza, oggi decreto). Poiché l’art. 1 l. 14 aprile 1982 n. 164 è esplicito nel disporre che il c.d. cambiamento del sesso, per avere effetti legali, deve essere dichiarato con la sentenza di «rettificazione di cui all’art. 454 c.c.» (e cioè con la sentenza di rettificazione dell’atto di nascita), ci si può
legittimamente domandare se, oggi che le sentenze di cui all’art. 454 c.c. non esistono più, ma sono state tutte sostituite dai corrispondenti decreti, anche la rettificazione per il cambiamento del sesso non debba farsi appunto con decreto. Il tribunale ritiene, peraltro, di dover dare risposta negativa al quesito e di dover quindi mantenere fermo che anche oggi la rettificazione per il cambiamento del sesso si fa con una sentenza (e ovviamente sempre con una sentenza dovrebbe essere, eventualmente, respinta l’istanza del ricorrente). E invero le parole identiche «rettificazione dell’atto di nascita» esprimono due realtà totalmente diverse, quando si tratti di attribuire a un soggetto un sesso diverso da quello originario, oppure, rispettivamente, quando si tratti di procedere a una rettificazione di qualsivoglia altro tipo di atto di nascita. Solo in questo secondo caso (che diremmo caso comune) può parlarsi propriamente di una rettificazione dell’atto di nascita (del quale si sia accertato un errore). Nel primo caso invece (che è quello che ne occupa), del tutto speciale, non si corregge (o elimina) alcun errore dell’atto di nascita, ma, molto più radicalmente, si accerta che, durante la vita del soggetto, alcuni cambiamenti sono intervenuti nella sua persona (che ora non occorre definire) i quali, per espressa volontà del legislatore, fanno sì che il soggetto medesimo, se era uomo, d’ora in avanti deve essere considerato donna e, viceversa, se era donna, d’ora in avanti deve essere considerato uomo; e di conseguenza si dichiara e in un certo senso si ordina che, ad ogni effetto di legge (al punto tale da determinare ipso facto lo scioglimento del matrimonio, se il soggetto era coniugato, e da dargli in ogni caso la facoltà di sposarsi con persona di sesso diverso — e solo con persona di sesso diverso — rispetto al sesso che ora gli viene attribuito ex novo), chi era uomo sia considerato donna e chi era donna sia considerato uomo. È perfettamente logico che effetti così dirompenti (che nulla hanno a che fare con una comune rettificazione di un atto di stato civile) conseguano a un provvedimento giudiziale rivestito della forma più solenne possibile, e cioè una sentenza. Ma, a parte siffatta «convenienza», in ogni caso la disposizione dell’art. 3, 2° comma, l. 14 aprile 1982 n. 164 deve considerarsi, per le ragioni ora spiegate, di natura speciale, anzi specialissima, di modo che essa non può ritenersi abrogata, neppure parzialmente, dalla norma generale sopravvenuta, contenuta nel regolamento dell’ordinamento dello stato civile. Ecco perché questa speciale «rettificazione» (che poi, come si è visto, propriamente una rettificazione non è) deve continuare a farsi con sentenza.
Passando a esaminare il merito della causa, si osserva che dalla certificazione prodotta risulta che il ricorrente, dopo la pronunzia della precedente sentenza, si è sottoposto a un’operazione chirurgica consistente nella totale asportazione di ambedue i testicoli, ma ha conservato integro il pene, e non ha neppure tentato di formare una vagina artificiale o qualcosa che ad essa somigliasse.
Si pone dunque il problema se siffatto parziale intervento chirurgico sia sufficiente per permettere la dichiarazione giudiziale di attribuzione (al ricorrente) del sesso femminile.
Al riguardo deve senz’altro respingersi la tesi estrema, adombrata dal procuratore del ricorrente, secondo la quale, per ottenere l’attribuzione del sesso diverso, nessuna operazione chirurgica sarebbe necessaria, ma sarebbe sufficiente che il ricorrente avesse un orientamento psicosessuale irreversibilmente femminile e avesse, mediante un opportuno trattamento farmacologico (ormonale), realizzato in sé stesso una completa femminilizzazione. Invero la norma speciale più volte citata esige espressamente un avvenuto «trattamento chirurgico», ovviamente interessante gli organi genitali, perché il tribunale possa attribuire al ricorrente il sesso diverso. Tuttavia la legge non precisa in che cosa, esattamente, debba consistere questo «trattamento chirurgico». Limitando l’indagine al mutamento di sesso da uomo a donna, perché solo questa è rilevante nella presente causa, non sembra che sia necessaria un’artificiale formazione di una vagina o di qualcosa che ad essa assomigli, in quanto che sarebbe illusorio credere che in tal maniera si possa dar vita a una donna vera. Si otterrebbe sempre e soltanto un simulacro di organi genitali femminili. La verità è che il legislatore, nel permettere il mutamento del sesso ope iudicis (pur sotto certe condizioni), ha posto in essere una fictio iuris, in quanto che è assolutamente impossibile trasformare un uomo in una donna (e viceversa). Ma allora, per supportare in qualche modo questa fictio iuris, non sembra necessario richiedere l’effettuazione di operazioni chirurgiche il più radicali possibile, considerato anche che esse comporterebbero inevitabilmente (atteso che, in questo campo, la ricerca scientifica e la pratica chirurgica sono ancora agli inizi) rischi non piccoli di insuccesso nonché il danno per il soggetto. L’esigenza, prevista dal legislatore, di effettuare un «trattamento chirurgico», peraltro non definito nei particolari, deve essere contemperata con il diritto del soggetto, costituzionalmente garantito, all’integrità fisica e alla salute. Ritiene pertanto il tribunale, tutto ciò considerato, che sia necessario e sufficiente, per un uomo che voglia diventare donna, una volta soddisfatte le altre condizioni, sottoporsi a un «trattamento chirurgico» consistente nella totale e irreversibile rimozione di quegli organi che permettono all’uomo di generare (appunto come uomo), ossia nella completa asportazione di entrambi i testicoli.
Poiché questo precisamente è stato fatto nel caso presente, come si è visto all’inizio, non resta che disporre senz’altro il mutamento del sesso del ricorrente, atteso che tutte le altre condizioni che la legge richiede per siffatta pronuncia sono state già accertate con la precedente sentenza.
Non può essere accolta la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il cambiamento del proprio prenome da Celeste (questo è il prenome attuale del ricorrente, a seguito di un decreto prefettizio, intervenuto in epoca anteriore all’inizio della presente causa, il quale aveva cambiato in tale guisa il prenome originario che era M.). La legge speciale sul mutamento del sesso tace completamente su questo argomento. Ma la giurisprudenza ha ammesso, in alcuni casi, il cambiamento del prenome, operato con la stessa sentenza che aveva disposto il mutamento del sesso. Ritiene il tribunale che il giudice abbia questo potere, solo quando il cambiamento del prenome sia indispensabile per evitare che, pur mutato il sesso, il soggetto continui a chiamarsi in un modo assolutamente incompatibile col nuovo sesso. Di conseguenza, in questa ipotesi, il tribunale dovrà cambiare la desinenza del prenome originario, così da adeguare il genere grammaticale a quello fisico; e ove ciò, in lingua italiana, sia impossibile (si pensi ad esempio a un uomo che si chiama Ugo e che con la sentenza diventa donna), il tribunale dovrà necessariamente imporre un nome nuovo. Più ampi poteri non sembrano essere concessi al giudice dalla normativa vigente, anche perché, come è noto, la legge prevede una speciale procedura amministrativa per chiedere il cambiamento del nome e individua nel prefetto l’autorità competente a disporre tale cambiamento. Nel caso di specie il ricorrente porta un prenome (Celeste) che è ambiguo (sia maschile che femminile), ma che viene molto più frequentemente imposto alle donne (più che agli uomini). Nessun inconveniente dunque se egli, ora che, ope iudicis, è divenuto donna, continuerà a chiamarsi Celeste.